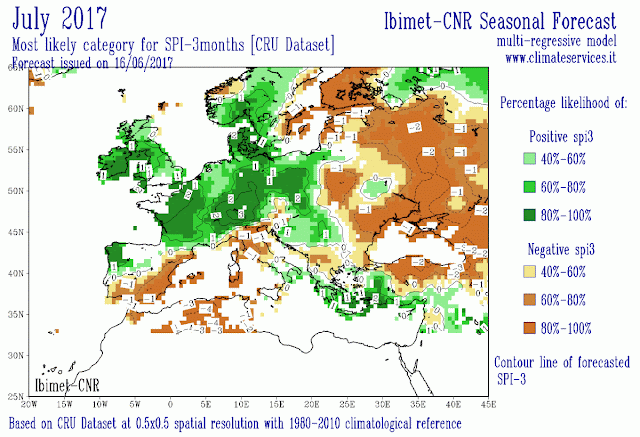Nella notte
fra il 9 e 10 settembre 2017, una intensa attività temporalesca ha interessato
le regioni tirreniche. La mattina seguente, la città di Livorno è risultata
gravemente colpita e con 8 morti.
L’impulso
di scrivere un post sull’argomento mi è arrivato da alcuni particolari di
questa vicenda: molte delle vittime si trovavano in seminterrati o scantinati,
quando, anche a causa di una tombatura non adeguata, un corso d’acqua è esondato,
riversandosi nelle strade della zona sud della città.
Ma partiamo
da due dati oggettivi:
In 3 ore
sono caduti localmente fino a 250 mm di pioggia, un valore che supera le stime
per eventi con tempo di ritorno di 500 anni.
La Regione
Toscana, nella giornata del 9 settembre, ha diramato una allerta meteo di alto
rischio (arancione) per 24 ore, a partire dalle 00:00 del 10 settembre.
Vediamo
quindi di capire cosa questo significa e, successivamente, cosa è successo.
 |
Idrogramma che mostra molto bene l'intensità di pioggia in così poche ore.
Immagine tratta dal sito sir.toscana.it |
Il Servizio Idrologico Regionale fornisce quelle che sono le linee segnalatrici, ovvero i
valori massimi di pioggia attesa per un tempo X di ore, per eventi che capitano
ogni Y anni. Valori comparabili con quanto accaduto a Livorno non se ne trovano. Il
massimo valore stimato per una pioggia di 3 ore con un tempo di ritorno di 500
anni è di circa 160 mm, quindi molto inferiore. Questa però
non deve essere una attenuante, poiché quanto è successo ha delle concause che
sono di una certa gravità da mettere in evidenza.
Il sistema
di allerta regionale (da poco uniformato a livello nazionale) si basa su tre livelli,
caratterizzati da un colore che può essere giallo, arancione o rosso. Dal
portale della Regione Toscana si può leggere a cosa serva questo sistema di
allertamento e come funziona:
- segnalare preventivamente la
possibilità di verificarsi di eventi meteo potenzialmente pericolosi;
- attivare presso i soggetti
istituzionali e le altre strutture operative la verifica della capacità di
intervento in caso di necessità
- mettere in atto alcune misure
di protezione preventive nei casi in cui queste siano possibili, come
previsto nei piani di protezione civile.
La
comunicazione dell'allerta è indirizzata anche ai cittadini, perché prestino
attenzione ai possibili rischi connessi ai fenomeni meteo e affinché adottino
comportamenti corretti durante gli eventi.
L'auto-protezione è infatti lo strumento più efficace per garantire la
propria sicurezza, soprattutto in caso di eventi repentini.

Nogarin, il Sindaco di Livorno, ha accusato il servizio di allerta meteo
di aver lanciato un allarme soltanto arancione e non rosso, che avrebbe
permesso di attivare ulteriori procedure di sicurezza. Da come sono riportati
sul portale regionale, è evidente come i due livelli di allerta siano
considerati insieme e in entrambi i casi tutti i soggetti interessati (Province,
Comuni, Prefetture, strutture operative, volontariato, gestori dei servizi e
della viabilità) devono essere pronti a intervenire. Personalmente, questo sembra uno scaricabarile poiché quando viene
diramata un’allerta arancione, il territorio deve essere monitorato
continuamente e, secondo l’evolversi della situazione, devono essere prese le
opportune decisioni ed informata costantemente la popolazione. Cosa che non è
stata fatta. Inoltre, visto che il
Sindaco ha fatto leva sulla drammatica presenza di vittime , domandiamoci
perché quelle persone si trovavano nel luogo meno indicato in caso di allerta
idrogeologica e perché si è creata questa situazione, visto che la differenza
di colore dell’allerta ha inciso poco o niente.
Il principale indiziato è il Rio Maggiore, la cui esondazione ha causato
alcune delle vittime che, purtroppo è triste dirlo a posteriori, potevano
salvarsi.
La Villa Liberty, dove si è consumata la tragedia, si trova in area a
pericolosità idraulica elevata, in adiacenza del tratto tombato del Rio
Maggiore: corso d’acqua che misura una lunghezza complessiva pari a 9.5 Km,
all’interno di un bacino idrografico stretto e lungo, con un sensibile sviluppo
longitudinale, con onde di piena che si manifestano con una forma allungata e
picchi di massima piena poco pronunciati.
Dagli anni ’20 agli anni ’60, a causa dell’urbanizzazione intervenuta
nella zona e per esigenze sanitarie, dal Cimitero della Misericordia fino alla
foce, il tratto terminale dell'asta è stato, per una lunghezza di circa 1 Km,
sostituito da un collettore.
Il Rio Maggiore è stato oggetto di uno Studio idrologico-idraulico
predisposto dal Prof. Stefano Pagliara su incarico dell’Amministrazione
comunale di Livorno dove sono state
1.Realizzate le cartografie recanti l’inviluppo delle altezze d’acqua di
esondazione per Tr ( 20, 30, 200 e 500 anni);
2.individuate le opere necessarie per la messa in sicurezza definitiva del
corso d’acqua (come da normativa secondo la piena con Tr 200 anni):
➢in primo luogo le casse d’espansione che, secondo le
verifiche volumetriche ed ingegneristiche eseguite, permettono di ricreare le
condizioni di generale messa in sicurezza idraulica del Rio Maggiore, non
soltanto in chiave del “Nuovo Centro”, ma soprattutto per le reali condizioni
di insicurezza che si riscontrano sul punto di tombamento.
➢altri interventi strutturali quali ricalibrature di
argini, di ponti, della sezione d’alveo in alcuni tratti ecc..
Sulla base delle risultanze Studio effettuato sul Rio Maggiore (nel
Progetto preliminare delle opere idrauliche per la sistemazione del Rio
Maggiore” ed approvato con parere favorevole dal Comitato di Bacino di rilievo
regionale Toscana Costa con prot. n.371 del 29 luglio 2009 http://www.comune.livorno.it/…/uploa…/2009_05_4_12_19_04.pdf ),
la messa in sicurezza idraulica del corso d’acqua è affidata alla realizzazione
di n. 4 casse d’espansione individuate come ASIP (Aree Strategiche per
Interventi di Prevenzione) i cui lavori sono, allo stato attuale, terminati e
l’opera collaudata dall’Ente preposto.
La Villa dove ci sono state vittime, che dovrebbe essere stata realizzata
degli anni ’20, si trova in un basso morfologico all’altezza del vecchio alveo
del Rio Maggiore, mentre Viale Nazario Sauro e via Rodocanacci sono ad una
quota di 3-4m maggiore e corrispondente probabilmente ad un vecchio terrazzo
alluvionale.
Durante la notte dell’evento temporalesco, le casse di espansione del Rio
Maggiore sono entrate in funzione ed hanno evidenziato la loro efficacia,
facendo diminuire la portata in entrata al punto di tombamento e limitando i
danni nella zona.
La domanda principale rimane quindi come l’acqua abbia fatto ad arrivare
alla Villa Liberty e così improvvisamente, senza lasciare scampo alle vittime, visti
i limitati danni e la limitata estensione dell’esondazione.
Dopo aver sentito una persona che abitava proprio li alla villa, si è
saputo che il collettore aveva un portellone di entrata per la manutenzione e
la pulizia, una apertura che permetteva l’ingresso anche ad un piccolo
escavatore. Quello che si è subito pensato è che la conduttura sia entrata in
pressione o per la portata in ingresso o per una parziale ostruzione e che
quindi il portellone (una debolezza strutturale del collettore) non ha retto la
spinta dell’acqua e che quindi sia “saltato” facendo defluire nel resede della
villa l’acqua del Rio Maggiore con una intensità tale da salire rapidamente
senza lasciare scampo agli abitanti del piano terreno. Dalla testimonianza
sembra anche che questo fatto sia già accaduto in passato, circa 37 anni fa. Da
un sopralluogo il portellone risulta però integro… Ci saranno comunque delle
indagini per chiarire la questione.
Se le vittime avessero saputo del rischio che stavano correndo,
probabilmente sarebbero salite al piano superiore per stare al sicuro. Per
questo sono due gli aspetti da affrontare: infondere alle persone non esperte
una coscienza geologica in grado di renderle consapevoli di un rischio in modo
autonomo; come propone il prof. Nicola Casagli dell’Università di Firenze e
riportato nel post di Massimo Della Schiava, che il sistema di allerta giunga
alle persone direttamente dal servizio regionale, mettendole allo stesso pari
dei soggetti che si devono attivare, eliminando un passaggio intermedio che
come si è visto è stato fatale.
Un altro punto su cui riflettere è su come e dove si costruisce. Lo
dicono in tanti (anche Nicola Casagli) e lo dico anche io da tempo, i toponimi
delle località non sono dati a caso: se un luogo si chiama Stagno, sarà bene
andare a vedere come mai e qual è la storia del luogo, per progettare meglio le
infrastrutture che si intende costruirvi o magari evitarlo proprio
(scelta consigliata, dico io).
Infine non può essere evitato l’ennesimo riferimento alla manutenzione,
la gestione dei corsi d’acqua e con esse il ringiovanimento delle opere
vecchie, visti anche i continui aggiornamenti normativi…
Si ringrazia Massimo della Schiava per il permesso a pubblicare parte di
un suo post.