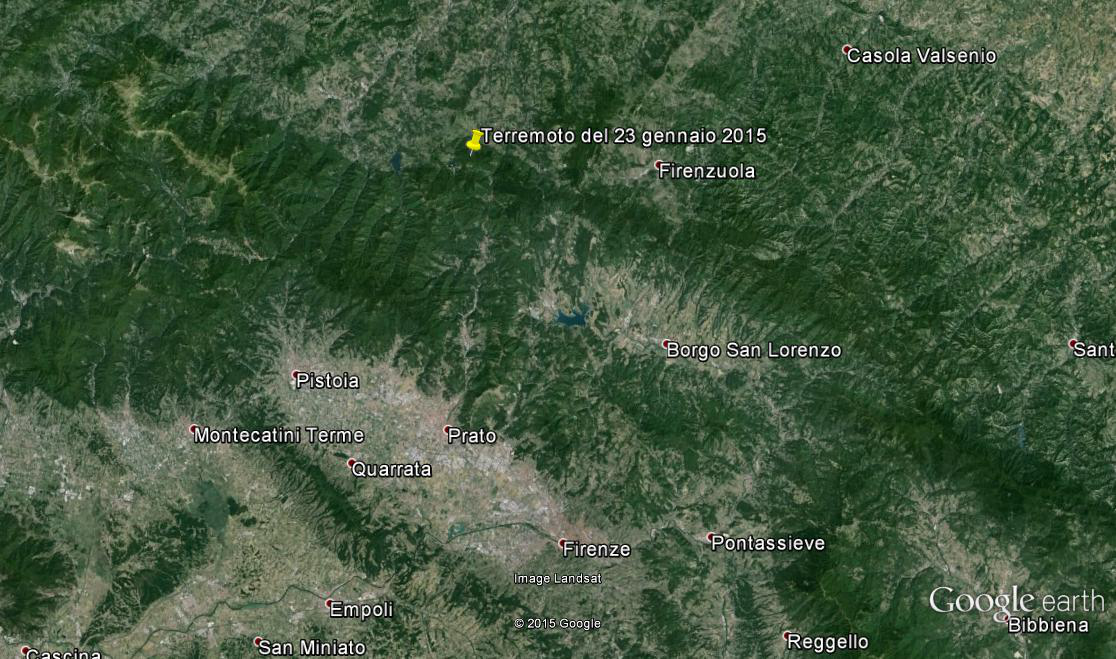Ho
letto su internet recensioni, post e chi più ne ha più ne metta di come mai il
terremoto di Ischia, pur non essendo forte, abbia provocato molti danni e
purtroppo anche due morti. Senza entrare nel merito della questione puramente geologica della causa scatenante il sisma, già molto complessa di per sé a causa della estrema variabilità litologica e geotermica (siamo nell'area vulcanica Ischia - Campi Flegrei - Vesuvio, ricordiamocelo!), vorrei soffermarmi sulle variabili che possono influenzare gli effetti di
un sisma sulle nostre abitazioni. Sono informazioni che pochi sanno e che mi
piacerebbe mettere in risalto.
Prima però voglio parlare della stima della magnitudo...
 |
| Casamicciola, zona dell'epicentro del terremoto di Ischia. Foto del blog INGVterremoti |
Prima però voglio parlare della stima della magnitudo...
Ogni volta la stessa storia, si dà una prima stima in automatico (ovvero è il "cervellone" dell'INGV che, entro due minuti, dà una prima stima per capire se la Protezione Civile deve mettersi subito in moto o meno) per
capire l’entità della gravità; in seguito, quando le elaborazioni dei dati (che
richiedono del tempo) vengono valutate e controllate a mano, si può confermare o
rettificare il valore di magnitudo, l'ipocentro e l'epicentro. Valore che è calcolato secondo diversi standard (ho già scritto su questo), secondo il tipo di evento o secondo il servizio geologico
nazionale dei vari Stati.
LA
PROFONDITA'
È
vero che l’energia di un terremoto con ipocentro molto profondo, viene
trasmessa alla superficie terrestre con effetti di scuotimento minori rispetto
ad uno di magnitudo equivalente ma con ipocentro superficiale. E’ vero però se la
differenza di profondità è di diversi chilometri: sapere se l’ipocentro si
trovi a 5 o 10 km serve dal punto di vista scientifico per capirne la sorgente (e 10 o 5 km nelle prime stime dei terremoti sono da imputare in automatico alle aree sismogenetiche: 10 km per le zone tettoniche, 5 km per le vulcaniche); gli effetti in superficie variano molto di più secondo altre variabili che
adesso vedremo.
 |
| Schema di faglia. Schema generale di come le onde sismiche si propagano nel sottosuolo. |
NATURA
DEL SOTTOSUOLO
La
velocità e l’ampiezza delle onde sismiche vengono modificate a seconda del tipo
di sottosuolo che attraversano durante il loro viaggio verso la superficie. Tutto
sta nel contrasto di densità fra un mezzo veloce (esempio arenaria o calcari compatti) ed un mezzo
lento come una coltre alluvionale. Esiste una relazione matematica per cui le
onde, se passano attraverso un mezzo a densità maggiore del precedente, aumentano di velocità e diminuiscono in ampiezza.
Contrariamente, se si passa attraverso uno strato a densità minore la velocità
diminuisce e l’ampiezza aumenta. Questo ultimo caso è quello più pericoloso: l’amplificazione
dell’onda sismica attraverso una coltre di materiale sciolto come le ghiaie, oppure un terreno a bassa densità, può generare uno scuotimento del terreno e danni ben maggiori di quanto ci si aspetterebbe con un substrato roccioso in
affioramento. Le variabili che incidono sulla velocità sono anche altre, come
ad esempio il grado di fratturazione dello strato roccioso (roccia più
fratturata, velocità più bassa) e presenza di acqua che assorbe le onde
sismiche secondarie (le onde di tipo S).
MORFOLOGIA
Non
solo la natura del sottosuolo può generare amplificazione, anche la topografia
può aumentare lo scuotimento indotto da un sisma. Un edificio posto in altura,
magari in cresta ad un rilievo, si trova nella condizione di subire anche l’oscillazione propria del rilievo su cui poggia: più esso è alto e con pendii
ripidi, maggiore è l’effetto amplificante che questi trasmette all’edificio in
questione.
Non
è detto poi che stare in pianura ci metta al riparo da possibili
amplificazioni… Un caso tipico è quello di una piana formata da alluvioni di
poche decine di metri sopra un substrato roccioso e compresa fra dei rilievi:
parte delle onde sismiche inizierebbero ad essere riflesse all’interfaccia roccia-alluvione
lungo i rilievi e rimarrebbero intrappolate in questo sistema chiuso,
all’interno della piana alluvionale. Questo provocherebbe sicuramente un
aumento del numero di treni d'onda che arrivano in superficie e per un tempo decisamente più
lungo.
FRANE
Da tenere in massima considerazione sono le frane che spesso accompagnano il post-terremoto. Le frane sono depositi di materiale eterogeneo che può essere facilmente movimentato attraverso lo scuotimento del terreno indotto da un sisma. La presenza di acqua nel corpo di frana e nei terreni scadenti, soprattutto se posti lungo pendii molto ripidi, può facilitare la movimentazione e, complice un'edilizia che negli scorsi anni non ha mai tenuto conto della morfologia del paesaggio, lungo il proprio percorso può trovare abitazioni e strutture e danneggiarle.
 |
| Gli effetti del terremoto. Foto tratta da Wikipedia |
ALTEZZA
FALDA
In
pianura si trova un caso particolare e tristemente famoso di un effetto
peggiorativo del terremoto: la liquefazione. I terreni granulari che hanno un
livello di falda molto vicino alla superficie sono i candidati perfetti. Le
particelle (le più adatte per questo fenomeno sono le sabbie pulite, ovvero
senza frazione fine come limi e argille) stanno insieme grazie all’attrito
generato dalla pressione fra i granuli stessi. L’acqua, attraverso la propria
pressione, tende ad allontanare le particelle fra loro e se si aggiunge un surplus di pressione dato
proprio dalle onde sismiche durante un terremoto, si arriva al punto in cui fra non esiste più contatto fra i
granuli. Il terreno quindi non riesce più a sostenere fondamenta e gli edifici vanno giù, magari senza crollare in mille frammenti ma
semplicemente ruotando, mancando la base d’appoggio.
COSTRUZIONI
Un discorso a parte merita la qualità costruttiva delle case. Gli abusi, la bassa qualità dei materiali e la troppa voglia di risparmiare su ciò per cui non si dovrebbe risparmiare: la sicurezza. Le case crollate ad Ischia, dal rilievo macorosismico dell'INGV, risultano essere in prevalenza case in mattoni, blocchetti di tufo e pietra squadrata ma non legate da alcun elemento vincolante! Le case in cemento armato hanno avuto invece danni generalmente solo alle tamponature. Chiaramente le case costruite a secco o con pietre tenute insieme da calce cruda (che se non mantenuta, diventa una specie di farina che non tiene più niente), hanno subito crolli; lo stesso vale per case nate per essere a un piano, successivamente appesantite da un secondo o terzo piano aggiuntivi, magari abusivamente.
Un discorso a parte merita la qualità costruttiva delle case. Gli abusi, la bassa qualità dei materiali e la troppa voglia di risparmiare su ciò per cui non si dovrebbe risparmiare: la sicurezza. Le case crollate ad Ischia, dal rilievo macorosismico dell'INGV, risultano essere in prevalenza case in mattoni, blocchetti di tufo e pietra squadrata ma non legate da alcun elemento vincolante! Le case in cemento armato hanno avuto invece danni generalmente solo alle tamponature. Chiaramente le case costruite a secco o con pietre tenute insieme da calce cruda (che se non mantenuta, diventa una specie di farina che non tiene più niente), hanno subito crolli; lo stesso vale per case nate per essere a un piano, successivamente appesantite da un secondo o terzo piano aggiuntivi, magari abusivamente.
IL GEOLOGO
Più un territorio è complesso e la costruzione è importante (non solo come volumetria, anche come tipo di utilizzo), maggiore dovrebbe essere il dettaglio geologico per poter dare agli ingegneri i dati necessari per costruire bene. Per questo si cerca di arrivare al fascicolo del fabbricato, dove ogni edificio ha la propria classificazione: ogni costruzione risponde in modo unico ad un sisma, maggiore è la conoscenza e migliore sarà la possibile risposta che è possibile dare per mettere in sicurezza persone e beni.
Quando sento dire che i geologi "rompono le scatole" nel fare le indagini in modo approfondito perché ci guadagnano di più, vorrei rispondere che oltre la responsabilità penale che ogni professionista si assume, c'è anche la passione per il proprio lavoro e nel dare un buon servizio che, in caso di calamità, può salvare la vita.
Fra spendere di più prima e spendere altrettanto dopo perché c'è da ricostruire (e rischiare di non sopravvivere all'evento), scegliete voi qual'è la soluzione migliore.
Più un territorio è complesso e la costruzione è importante (non solo come volumetria, anche come tipo di utilizzo), maggiore dovrebbe essere il dettaglio geologico per poter dare agli ingegneri i dati necessari per costruire bene. Per questo si cerca di arrivare al fascicolo del fabbricato, dove ogni edificio ha la propria classificazione: ogni costruzione risponde in modo unico ad un sisma, maggiore è la conoscenza e migliore sarà la possibile risposta che è possibile dare per mettere in sicurezza persone e beni.
Quando sento dire che i geologi "rompono le scatole" nel fare le indagini in modo approfondito perché ci guadagnano di più, vorrei rispondere che oltre la responsabilità penale che ogni professionista si assume, c'è anche la passione per il proprio lavoro e nel dare un buon servizio che, in caso di calamità, può salvare la vita.
Fra spendere di più prima e spendere altrettanto dopo perché c'è da ricostruire (e rischiare di non sopravvivere all'evento), scegliete voi qual'è la soluzione migliore.